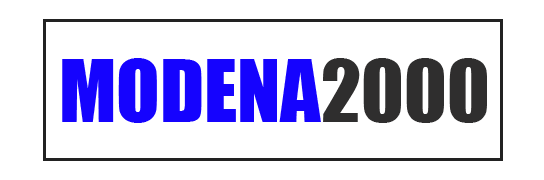Doppio appuntamento a Modena e Reggio Emilia di studiosi del linguaggio, organizzato dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura, dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dall’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
L’iniziativa dedicata allo studio di linguaggio, lingue e cervello “Scimmie parlanti: linguistiche e altre scienze naturali”, si aprirà a Modena nell’Aula Magna dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti (Corso Vittorio Emanuele 59) mercoledì 2 febbraio alle ore 17.00 con una tavola rotonda su “Storie di lingue e di cervelli”, coordinata dal prof. Augusto Carli della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in cui la facoltà del linguaggio verrà illuminata da vari approcci disciplinari.
Il giorno successivo, giovedì 3 febbraio a partire dalle ore 10.00 l’appuntamento proseguirà a Reggio Emilia presso il Complesso universitario ex Caserma Zucchi (viale Allegri 9) con una sessione plenaria aperta dal prof. Guido Babujani dell’Università di Ferrara e sarà poi ripartita in due workshops paralleli per entrare nel vivo di una discussione che “ruoterà – spiega il prof. Augusto Carli – intorno a due prospettive sullo studio del linguaggio verbale umano, che trovano un cruciale punto di unione nel fatto che entrambe si basano sulla visione del linguaggio come parte integrante della struttura biologica umana e dunque si pongono in un contesto di complesse relazioni con le diverse discipline che studiano la <natura umana>”.
Il paradigma della biolinguistica storica. L’orientamento della ‘biolinguistica”, orientato su due prospettive, la prospettiva evolutiva e la prospettiva storicogenealogica trae le ragioni stesse della propria esistenza dalla collaborazione e interazione con le scienze biologiche, prima fra tutte la genetica evolutiva e l’antropologia delle popolazioni (Di Sciullo 2009). D’altra parte, la linguistica
storica negli ultimi anni ha applicato tecniche di analisi matematico-computazionale dei dati, elaborate proprio a partire dai metodi costruiti dai biologi, per la ricostruzione delle relazioni storico-genealogiche fra le lingue e cioè per la tassonomia storico-comparativa (Russell e Gray 2003, Mc Mahon e Mc Mahon 2005). La prospettiva storica sullo studio del linguaggio verbale umano ha beneficiato inoltre dei recenti sviluppi teorici prodotti nell’ambito degli orientamenti formali (Roberts e Roussou 2003). “L’interazione, pertanto, fra l’applicazione dei metodi tassonomici computazionali elaborati nell’ambito delle scienze biologiche e l’adozione dei metodi formali per lo studio della variazione sintattica (teorie parametriche), – dice una delle organizzatrici la dott. ssa Cristina Guardiano dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – promette di rinnovare una relazione, quella fra biologia evoluzionistica e linguistica storica, che almeno dalla metà del 19esimo secolo ha seguito percorsi e obiettivi paralleli nella ricostruzione delle relazioni storiche fra popolazioni e lingue umane (Longobardi e Guardiano 2009). Fin dalla predizione di Darwin (1859, ch. 14) infatti, e soprattutto con i lavori di Luigi Luca Cavalli Sforza (Cavalli-Sforza et al.,1988, 1994), si è tentato di mostrare il parallelismo fra l’evoluzione biologica delle popolazioni umane e la trasmissione culturale delle loro lingue, mettendo a confronto le classificazioni delle popolazioni basate prima sui caratteri antropometrici e poi sui polimorfismi genetici con una serie di classificazioni linguistiche basate su caratteri lessicali, e in alcuni casi, peraltro, altamente discutibili”.
Una serie di ambiziosi progetti di ricerca attualmente in corso propone adesso una nuova prospettiva su questa relazione, suggerendo un confronto sistematico fra i risultati della genetica e quelli della linguistica basato sull’individuazione di caratteri tassonomici originali. In un contesto così in evoluzione la costante interazione fra studiosi e la condivisione di metodi e risultati sono essenziali per l’avanzamento stesso della ricerca: l’incontro delle Scimmie parlanti proporrà una discussione informale fra studiosi provenienti da tutti i settori sopracitati, finalizzata non solo alla condivisione di interessi, metodi e obiettivi ma anche all’individuazione di comuni prospettive di ricerca future.
Il paradigma della neurolinguistica. Il contributo della linguistica acquisizionale e interazionale alla riabilitazione del linguaggio afasico. “La prospettiva della neurolinguistica – spiega un’altra organizzatrice la dott. ssa Elena Favilla dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – considera che il funzionamento del linguaggio umano, in quanto prodotto del cervello umano, può essere compreso solo integrando le conoscenze di varie discipline e superando la tradizionale scissione tra scienze naturali e scienze umane”. In questo contesto lo studio dei rapporti tra competenza linguistica e metalinguistica può aiutare a comprendere meglio il funzionamento del linguaggio. Se, in assenza di patologie specifiche, tutti gli esseri umani esposti ad una lingua sviluppano una competenza linguistica già a partire dai primissimi anni di vita, con la scolarizzazione tale competenza viene sistematizzata e consolidata attraverso la sollecitazione di riflessioni esplicite sul funzionamento della lingua. “In un soggetto adulto – prosegue la dott. ssa Elena Favilla – adulto, l’elaborazione del linguaggio implica necessariamente un’interazione tra competenza linguistica e metalinguistica. Ma come è organizzata tale interazione nel cervello? Come interagiscono la competenza linguistica, acquisita spontaneamente attraverso l’esposizione all’input linguistico dei parlanti di una determinata società, e la competenza metalinguistica, appresa attraverso l’insegnamento esplicito? Quali effetti può avere una maggiore o minore competenza metalinguistica sulle capacità di un parlante di produrre e comprendere le frasi della propria lingua nelle varie situazioni e nei vari contesti? La competenza linguistica rafforza i circuiti neurali coinvolti nell’elaborazione del linguaggio o implica l’attivazione di circuiti alternativi?”.
Le risposte a queste domande possono fornire indicazioni utili non solo per ampliare le conoscenze sul funzionamento del linguaggio nel cervello, ma anche per l’elaborazione di metodi per l’insegnamento delle lingue, sia native che seconde, e per il recupero del linguaggio in soggetti affetti da patologie linguistiche.
A questo scopo, ci si propone di mettere a confronto e discutere dati ricavati dalle diverse prospettive possibili, tra cui in particolare vari settori della linguistica applicata, quali sociolinguistica, linguistica acquisizionale ed educazione linguistica, psicolinguistica e neurolinguistica, alla luce delle conoscenze sull’organizzazione e sul funzionamento del linguaggio nel cervello conseguite, anche con il contributo degli studi di immagine, nell’ambito delle scienze neurologiche.
Per informazioni: cristina.guardiano@unimore.it; elena.favilla@unimore.it